|
|
|
| Assedio
e distruzione |
|
Il cardinale
Vitelleschi, patriarca titolare di Alessandria, generale dei pontefici,
agiva per conto di Eugenio IV a favore di Renato, ultimo di Casa d'Angiò,
contro Re Alfonso I che dalla Sicilia aveva occupato il regno.
Alife si arrese subito, e fu risparmiata. Piedimonte invece, forte della
sua posizione e incoraggiata per la presenza del suo signore, Cristoforo
Gaetani, resisté parecchio. Arresasi in basso, popolazione, combattenti
e barone si asserragliarono in alto. Ma il castello si dovette arrendere
e, per la rabbia, il Vitelleschi ne ordinò l'abbattimento, tanto ci
aveva stentato. Cristoforo Gaetani si salvò sulle montagne. |
| Prima
inondazione |
| La prima inondazione gravissima di
Piedimonte bassa è riportata dal Summonte nella Storia del regno di
Napoli (to. IV, li. XII, pag. 427), secondo il quale ci furono sui
400 morti in tutta la zona. Era il 1° ottobre 1581. |
| Congiura
dei baroni |
|
Contro le imposte,
decretate da Re Ferdinando I, i signori del regno reagirono ribellandosi
in massa. Rimasero col Re tre soli signori: i conti di Taranto, Melfi e
Fondi (Onorato Gaetani). Quando fu chiaro che papa Innocenzo VIII
aizzava i baroni, s'unirono al Re Milano e Firenze.
Onorato si chiuse nei suoi fortilizi piedimontesi. Ed ecco sul posto
l'esercito baronale. Siamo nei primi mesi del 1460, pare in maggio.
Proposte tentatrici andarono a vuoto e i piedimontesi lasciarono un bel
nome di popolo fedele e coraggioso (....seppure disposto a pagare
maggiori tasse). Resisté Piedimonte bassa e il castello in alto.
L'esercito, infuriato ed irritato, devastò la vallata e la piana di
Piedimonte. Era anche una vendetta voluta dal ribelle Marzano per il
saccheggio precedente di Alife da parte dei piedimontesi.
Ma la resistenza di Onorato a Piedimonte era dovuta non a disinteressata
fedeltà al Re, ma al fatto che aveva avuto poco...... Il principe di
Rossano gli aveva fatto capire che per Traetto (oggi Minturno) e tutte
le terre presso la foce del Garigliano, già feudo dei Gaetani, c'era
niente da fare. Servivano a lui. Questi gran signori di ligi vassalli
avevano solo il nome. Facevano i loro conti: a te questo, a me questo.
Gli scontenti del baratto levavano una bandiera avversa. Pare che il
difetto non sia finito, ma che anzi si sia.....democratizzato. |
| La
peste |
|
La peste del 1656 fu
una calamità spaventosa. introdotta in Maggio dai soldati spagnoli fece
morire un milione di persone in tutto il reame (secondo altre fonti la
cifra si riduce alla metà).
In Piedimonte e nei piccoli borghi metà della popolazione rimase
distrutta, qualcosa come 4.500 morti! Ogni ricostruzione è inutile di
fronte alle cifre, eloquenti per se stesse. Da Piedimonte molti
appestati erano portati a Castello, dove si pensava che l'aria pura
avesse portato giovamento. |
| Seconda
inondazione |
|
Il 26 settembre 1728
altra alluvione rovinosa. Protagonista, il Rivo.
Il vallone Paterno si alzò di 14 palmi. Fu a parecchie ondate e nella
chiesa del Carmine l'acqua superò gli altari. All'alba, sotto l'acqua
si organizzò la processione di San Marcellino, e si ebbe il sereno
improvviso. In quella notte di orrore: |
|
<<.....formano
pianti e grida, urli e lamenti
un indistinto suono e fa maggiore
lo spettacolo orrendo i suoi spaventi>>. |
|
Così uno degli Arcadi
descrive la disperazione di Piedimonte. Ci furono due carcerati fucilati
mentre tentavano la fuga, e alcuni annegati. I danni furono tanto gravi,
stando alla cronaca del Not. Alessandro di Franza di Dragoni. |
|
Carlo di Borbone a
Piedimonte |
|
Parentesi lieta a tanti
lutti la venuta a Piedimonte dell'infante Carlo di Borbone. L'unico
esercito che non abbia fatto danno (rovinò solo la strada dei pioppi),
fu questo, composto da 12.000 Spagnoli.
Dopo la battaglia di Bitonto, vittoriosa per le armi borboniche, gli
Austriaci lasciarono il regno di Napoli e l'Infante Don Carlo occupò
rapidamente il Regno proveniente dalla Puglia.
Da San Germano, e per la scafa di Raviscanina, il giovane ed
intelligente conquistatore giunse a Piedimonte il 6 aprile 1734,
ricevuto festosamente nel rinnovato Palazzo ducale dal vecchio duca
Nicolò che, colla fine del Vicereame e la dinastia sul posto, vedeva la
rinascita della Patria. Don Nicolò, all'ingresso attuale di palazzo
ducale, fece la genuflessione, e con quest'atto lo considerò proprio
sovrano (esponendosi alla pena di morte se a Bitonto avessero vinto gli
Austriaci). Dopo l'abate-feudatario di Montecassino, che a San Germano
aveva compiuto il gesto per primo, don Nicolò fu considerato a corte,
come il secondo barone del reame.
Mentre l'esercito si accampava lungo la via dei Pioppi, il conquistatore
presiedeva a palazzo ducale un consiglio di guerra col duca di
Castropignano. Ed ecco l'arrivo di un'ambasceria della fedelissima città
di Napoli. Gli eletti lo vogliono nella capitale per il riconoscimento
ufficiale. Questo fatto è sfuggito a tutti: il primo riconoscimento
de facto della dinastia borbonica è avvenuto a Piedimonte. Il
principe partì il 7, festosamente acclamato. Il Trutta ricorda con
entusiasmo l'avvenimento. Il letto in cui dormì l'infante di Spagna fu
conservato dai Gaetani fino al 1943, quando rimase distrutto
dall'incendio del palazzo. |
| Terza
inondazione |
|
Il 20 novembre 1778 una
nuova alluvione. Si scatenarono Vallone e Rivo. Distrutto il muraglione
del 1775 Vallata fu inondata, e la gente atterrita riparò ai piani
superiori delle case. Anche stavolta il povero convento del Carmine fu
invaso e l'acqua raggiunse in chiesa i due metri. Il Rivo riempì
l'androne sotto il palazzo vescovile e si riversò per San Domenico.
Attraverso la stalla, penetrò nel convento domenicano. I morti furono
tre, e le perdite furono gravi, anche ad Alife. |
| L'invasione
francese e il saccheggio |
|
Il regno di Napoli era
entrato nella prima coalizione contro la Francia, non solo, ma nel 1798
l'esercito borbonico aveva occupato Roma sia per sostegno al papa, che
per garanzia ai suoi confini.
L'esercito francese invase il Regno. Re Ferdinando s'imbarcò per
Palermo e a Napoli Championnet e Macdonald proclamarono la repubblica
Partenopea, superando con grande sforzo la disperata resistenza dei
"lazzari".
Appoggiarono gli invasori e aderirono alla repubblica
"partenopea" alcuni esponenti della nobiltà e della
borghesia, e perfino ecclesiastici. Quelli provenivano dall'Illuminismo,
questi dal Giansenismo. Coi francesi tornarono a Napoli anche alcuni
fuorusciti, e fra essi c'era il nostro
Ercole
d'Agnese.
A Piedimonte i francesi comparvero il 7 gennaio 1799, comandati dal
generale Le Moyne. La popolazione apertamente borbonica si era armata,
ed essi, portatori di libertà, uguaglianza e fratellanza, imposero
subito per "castigo" una taglia immediata di 2.000 ducati da
pagarsi insieme a Castello e San Gregorio, oltre al vettovagliamento.
Scoppiò subito la sommossa - l'8 gennaio - a Vallata. Campane a
martello e fucilate dalle finestre e assalto in tre colonne al quartiere
francese. Ma era quello che voleva l'esercito "liberatore",
che si abbandonò al saccheggio e alle violenze più schifose nelle
case. Avvenne tutto in un momento. La popolazione abbandonò in massa il
paese, rifugiandosi sulle montagne piene di neve. I monasteri femminili
furono lasciati nottetempo dalle monache e da quello di S. Salvatore,
subito presidiato, le monache fuggirono dopo aver fatto un buco nel
muro. Ne rimase una mezza paralitica, che fu uccisa con una sciabolata
dalla soldataglia.....delusa. Il vescovo Gentile dovette rifugiarsi
anch'egli a Napoli. E intanto a Piedimonte la soldataglia si presentava
armata in S. Maria intimando: "Argent, argent!". Tutta
l'argenteria - 12 calici, incensieri, lampade, campanelli, cartegloria -
fu portata via. Fu tolta la testa d'argento della statua di S. Felice
mart., e le reliquie, che vi erano custodite, furono frantumate sotto
gli stivali dei ladri francesi. Le ostie consacrate erano gettate a
bella posta. Anche i paramenti furono portati via e servirono a
improvvisati e irriverenti tripudi. Come,in mezzo a tutto quest'assalto
si sia salvato S. Marrcellino, non si sa. Certo, seppe di straordinario,
poiché tutto fu tolto. Il Monte dei pegni, con lavoro assiduo di oltre
150 anni messo su dai confratelli del Rosario, fu svaligiato in un
baleno dei pegni di oro e di argento. Nel palazzo vescovile lasciarono
niente, dice il vescovo Gentile nella relazione ad sacra limina,
neanche lo spiedo del focolare, ne veru quidem relicto.
Naturalmente le perdite più forti l'ebbe il duca Gaetani. Il duca
vecchio, D. Nicola, aveva seguito il Re a Palermo, e a Napoli, la
duchessa, con dieci figli, sapeva dal credenziere Ragucci quel che era
successo.: la farina, l'olio, mobili e oggetti d'arte rubati, le piccole
e fruttuose industrie devastate, i depositi della dogana alla mercé dei
soldati..... Molti furono feriti dalle fucilate mentre fuggivano. Ben 14
civili furono uccisi. Ma anche i francesi ci lasciarono la pelle.
Finalmente, dopo cinque giorni di delinquenza, la truppa fu richiamata a
un pò d'ordine, e Le Moyne fece menar bandi, perché tutti tornassero
in paese. Uscirono dalla soffitta della chiesa S. Francesco tutte le
ragazze che v'erano rinchiuse. La popolazione tornò per forza, dato il
rigido inverno e visse mesi sotto la paura.
Il Governatore di Piedimonte, fedele al Sovrano, fu espulso dalla
città, e la sbirraglia, tramite i due spauriti sindaci Paterno e Pscale,
eletti nel dicembre del 1798, guazzava, mentre i nostri soffrivano la
fame e il freddo. I soliti malcontenti ed arrivisti furono valorizzati.
Governatori, sindaci ed eletti furono imposti da Le Moyne in una
"Municipalità" con a capo logicamente il fratello del
d'Agnese, Domenico, e alla Crocevia, al Mercato, e all'Annunziata fu
piantato l'albero della Libertà: una mazza con un beretto frigio sopra
i nastri. Quattro mesi dopo tutto questo sconquasso, comparve Ercole
d'Agnese.
(cronaca dei fatti in un manoscritto d'epoca) |
| Invasione
franco-austriaca |
|
Nel gennaio 1806
l'invasione francese si ripeté, stavolta monarchica, e durò nove anni.
Dopo sedici anni si ebbero di nuovo momenti critici, e stavolta per
fortuna furono evitate scene penose alla nostra città. Murat era stato
mandato via, e i suoi sbandati cercavano rifugio predando.
A Piedimonte il settembre 1814 arrivò la notizia che una banda di circa
700 di questi disperati si stava avvicinando a Gioia, e, per la verità,
lo spavento fu grande. Il più minacciato era
Egg
che organizzò però subito la difesa.
Armò i suoi svizzeri, e siccome i fucili non bastavano, dette a 30 dei
più forti, le clave di ferro, arma nazionale elvetica tradizionale.
La notizia si diffuse subito. La nostra popolazione s'era armata
anch'essa e aspettava l'assalto..
Senonché i muratiani, o briganti che fossero, mutarono itinerario.
Andati via i muratiani, arrivarono 100 austriaci, venuti apposta per
scacciare quelli. Requisivano bovini, vollero denaro dal Comune, ma in
compenso non molestarono nessuno. Anzi gli svizzeri, operai di Egg,
fecero da interpreti, e ci fu quasi un buon accordo colla popolazione
che vedeva in essi i difensori dell'ordine.
S'erano accasermati al cotonificio e il sindaco De Benedictis dette in
15 giorni quello che volevano. |
|
"La Legione del Matese"
e l'occupazione di Piedimonte |
|
Dopo che si era
costituita a Piedimonte una legione garibaldina denominata "La
Legione del Matese" (nell'agosto 1860 il comitato centrale
dell'organizzazione dell'Ordine e dell'Unità inviò l'abruzzese Giuseppe
De Blasiis in Terra di Lavoro e gli conferì, col grado di maggiore, il
comando della "Legione del Matese" formata da B. Caso) eccoci arrivati alla sera del 22 settembre 1860
quando la colonna garibaldina guidata dall'ungherese Csudafy organizza
la difesa contro il rinato esercito borbonico, che dopo aver ripreso ed
incendiato Caiazzo si appresta ad arrivare a Piedimonte.
Infatti il
Brigadiere Von Mechel
ebbe
ordine dal Ten.Generale Ritucci, il 23 Settembre, dietro
disposizione Sovrana dello stesso giorno, di muovere colla sua Brigata
estera da Caiazzo per marciare il 24 ad Alvignano per poi
attaccare il 25 i Garibaldini in Piedimonte di Alife, prima del giorno,
coadiuvato dal Colonnello Ruiz con un'altra Brigata di frazioni napoletane.
"E' intenzione di S.M. che dopo l'attacco di Piedimonte d'Alife...,
Ella..., dopo non più che un giorno di riposo alle sue truppe, con tutta
la Colonna di suo Comando, comprese le Truppe di Ruiz, e con le debite
prevenzioni prenda la volta di S. Potito, Trivio, Casale di Faicchio,
Amorosi, Ducenta, Valle e pei Ponti della Valle piomberà alle spalle di
Caserta, impadronirsene, spingersi sulla strada di S. Maria per
giungervi alle spalle, mentre una divisone che uscirebbe da Capua
l'attaccherebbe di fronte e dal fianco per S. Tammaro."
Csudafy organizzò la difesa con avamposti
all'Epitaffio, presso la
Porta Ferdinandea (Vallata), e sulla collinetta al ponte di Sepicciano,
e accendendo fuochi da M. Stufo alle colline di Sepicciano. Ma il 23
settembre,
precipitando ormai le cose, le Camicie rosse si ridussero in città,
barricando tutte le entrate, e specialmente Palombara e Porta Ferdinandea. I Regi arrivavano da Caiazzo!
Csudafy, impegnato nei pressi di Roccaromana,
teneva Piedimonte d'Alife con un forte distaccamento garibaldino.
Secondo quanto riporta lo storico B. Cognetti, "Csudafy non
si sentiva sicuro in questa città, essendo continuamente minacciato dalla
popolazione quasi tutta appartenente al partito borbonico», come
confessa lo stesso Rustow, Capo dello Stato Maggiore di Garibaldi."
Senza sapere che i governanti
locali avevano già inviato un
solenne proclama di sottomissione all'Invittissimo Giuseppe Garibaldi, in data 9
settembre 1860 (Atti del Governo
estratti dal giornale officiale di Napoli, 7-10 settembre 1860),
tant'é che i garibaldini nell'entrare in Piedimonte non avevano trovato
alcuna resistenza. Ma ora il popolo piedimontese, sapendo dell'arrivo
dell'esercito borbonico, cominciò a tumultuare contro i garibaldini, e i liberali
perdettero la testa. Pertusio urlava che era inutile resistere, ed era
meglio che Csudafy se ne andasse. Su questo premeva anche il vescovo Di
Giacomo[1] e tutti gli esponenti borbonici. Ma subito! I Regi stavano alla
scafa del Volturno (oggi Ponte Margherita).
Così la notte tra il 24 e 25 settembre il magg. Csudafy, bloccato a
Roccaromana dai regi ecircondato da forze superiori, abbandonò
Piedimonte e ripiegò precipitosamente verso Amorosi; svanita
l'impellente necessità di scacciare i garibaldini da Piedimonte prima
d'intraprendere qualsiasi azione offensiva, il 26 il maresciallo Ritucci
modificò in parte lordine del giorno precedente e ordinò al brigadiere
Von Mechel d'attuare celermente il disarmo a Piedimonte con il magg.
Aloisio Migy (2° battaglione Carabinieri) che, poi, avrebbe dovuto
ritornare "subito verso Cajazzo, unendosi al resto della brigata con
l'intera Colonna, ecc....".
In realtà con l'avvicinarsi dei borbonici, tutte le famiglie
liberali fuggirono in giornata sulle montagne e, alle 11 di sera del 24,
la stessa colonna garibaldina, circa 600 uomini, lasciò Piedimonte, e sostò durante la
notte su S. Pasquale. Il giorno seguente Csudafy, con il suo
distaccamento, fu costretto a dirigersi verso i
monti di Vairano. Per cui a Piedimonte non ci fu alcuna resistenza
all'ingresso dei borbonici. Le poche scaramucce che avvennero sino al 1° di ottobre furono
di breve momento, a meno del combattimento di Monte Vairano. Il vescovo, il principe Gaetani e Gaspare Egg
subito fecero rimuovere le barricate e tutti si diressero in
carrozza alla scafa: a Piedimonte non c'è alcuna resistenza (che era
come dire: Fate a meno di venirci).
L'occupazione di Piedimonte era voluta da Re Francesco in persona, ed
era stata prevista dal conte di Aquila la distruzione del paese, se ci
fosse stata resistenza. Colle spalle al sicuro i Borbonici avrebbero
riattaccato sul Volturno.
Allora la Legione si mosse lungo il costone del Matese
fino a Pettoranello (IS) seminando morte e violenza tra gli uomini, ma anche
tra donne e bambini. Diversi furono i paesi distrutti dal suo passaggio,
tra i quali Roccamandolfi e Sant’Agapito. A Pettoranello i seguaci di
Garibaldi trovarono ospitalità dall’arciprete del paese, sostenitore
degli ideali carbonari. Durante questa sosta i Sanfedisti di Isernia
colsero l’occasione per armare i contadini e uccidere, la notte del 20
ottobre 1860, i membri della Legione che, colti di sorpresa subirono una
vera e propria disfatta.
L’episodio più grave fu quello che seguì quel tragico 20 ottobre. Le
donne accecate di vendetta evirarono i corpi già cadaveri dei patrioti e
li impiccarono lungo il tratturo fino a Carpinone. La reazione delle
donne fu chiamata “furia delle donne cagne scatenate”. Ad essa seguì la
risposta con le armi del generale Cialdini che fu costretto a scendere a
Isernia e a fucilare centinaia di Sanfedisti al fine di sedare la
ribellione.
L’episodio oscurò i rapporti tra il nuovo Stato e la gente isernina,
tanto che lo stesso Garibaldi dovette scendere a Isernia, per proclamare
un discorso di pace incentrato sulla tradizione sannita, richiamando
l’episodio delle Forche Caudine come modello di unità della penisola in
funzione antiromana.
Il 6 ottobre stava a Piedimonte il generale Scotti Douglas con 1500
uomini. Su indicazioni del Raffaele Gaetani andò ad occupare il
Macerone, ma si trovò di fronte ai Piemontesi e fu fatto prigioniero.
Gli si trovò addosso la lettera del Gaetani, e perciò questi che lo
aveva consigliato, il 22 ottobre, insieme ai regi, lasciò Piedimonte
colla famiglia. Andò a Gaeta e poi a Roma, dove rimase presso il Re
fino al 1867.
Il 26 ottobre nuovo copovolgimento: i Sabaudi dilagavano e i generali
Della Rocca e de Sonnaz si congiunsero presso Alife. il 7 novembre a
Piedimonte non ci fu plebiscito, ma di notte i Borbonici, lasciarono il
paese per l'ultima volta. L'8, corteo questa volta liberale inneggiante
alla Unità, a Casa Savoia e a Garibaldi.
Ed ecco tornare allora i nostri legionari. Vendette e terrore
garibaldino a Piedimonte!
Con decreto di Vittorio Emanuele II, voluto dal Cavour, le forze
volontarie furono in gran parte sciolte. La legione ebbe l'incarico di
tenere l'ordine in Terra di Lavoro: da volontari a carabinieri era pure
il desiderio dei nostri, ma non ottennero che sei mesi di paga e il
licenziamento.
L'8 marzo, a Caserta, la Legione del Matese coi suoi 240 uomini, fu
passata in rivista, e consegnò le armi. Il 14 fu sciolta. Colle solenni
esequie a Cavour in S. Maria, il 28 giugno, si chiuse a Piedimonte la
pagina del Risorgimento. (I
Fatti di Piedimonte raccontati dallo storico Giacinto De Sivo)
COMPONENTI DELLA LEGIONE DEL
MATESE –
I cittadini
che vi avevano preso parte, secondo le indagini del Petella furono:
Altieri Raffaele, Altobelli Pietro, Azza Giuseppe, Balsamo Giuseppe,
Balsamo Luigi, Barbato Raffaele, Buontempo Giuseppe, Capone Ottavio,
Cappella Pasquale, Caruso Vincenzo, Cassella Pasquale, D’Amico Michele,
D’Amico Raffaele, De Biase Pasquale, De Biase Raffaele, De Lisi Felice
Antonio, De Luca Pasquale, Di Matteo Cosimo, D’Orsi Vincenzo, Fontanella
Raffaele, Fragola Federico, Fragola Raffaele, Francese Luigi, Francese
Salvatore, Gagliardi Giovanni, Galeno Salvatore, Gallino Ignazio, Gardon
Giovanni, Gasbara Filippo, Gaudio Luigi, Gaudio Samuele, Giordano
Giuseppe, Giordano Pasquale, Giordano Pietro, Giordano Raffaele,
Giorgini Antonio, Girardi Marcellino, Giuliano Vincenzo, Giuseppe
Pasquale, Grande Samuele, Gravante Lorenzo, Grifo Leonardo, Grillo
Adamo, Iannotta Giuseppe, Iasalvatore Vincenzo, Imondi Angelo, Mandaro
Lorenzo, Manzi Michele, Marchitti Pasquale, Marappese Salvatore,
Marappese Silvestro, Marrocco Oronzio, Marrocco Michele, Marrocco
Giuseppe, Marrocco Raffaele, Meola Gaetano, Messere Alfonso, Messere
Luigi, Messere Michele, Messere Silvestro, Miglione Luigi, Navarra
Giovanni, Orsini Girolamo, Pacelli Giovanni, Pacifico Antonio, Pepe
Francesco, Pepe Girolamo, Pingitore Nicola, Pinque Francesco, Pirollo
Angelo, Pisanti Francesco, Pisanti Raffaele, Santagata Filippo,
Santangelo Raffaele, Santelli Vincenzo, Santillo Nicola, Tartaglia
Giuseppe, Terenzio Luigi, Terribile Biagio, Torti Nicola e Toto Gaetano.
[1] Il vescovo di
nette e ben note tendenze liberali , che gli valsero nel 1863 la nomina
a Senatore del Regno, e che, in pieno dissenso con le direttive del
papa, prese parte attiva ai lavori parlamentari. Egli addusse il
pretesto della cattiva salute per non partecipare al Concilio. (G.
Martina, Appunti storici sopra il Concilio Vaticano, Ed.
Università Gregoriana, Roma 1972) |
|
La
Ferrovia Napoli - Piedimonte d'Alife |
|
Rimasta
a 25 km. da Telese e a 34 da Caianello, Piedimonte avvertì il bisogno
di una linea diretta per Napoli (I viaggi per Napoli duravano
praticamente una giornata, e tipici erano quelli dei Gaetani in grandi
carrozze, con lacché a cavallo).
Progetti e petizioni si seguirono. Nel
1898 ci fu perfino la proposta di prolungare la tramvia Napoli-Aversa
fino a Piedimonte. L'Amministrazione provinciale concesse un sussidio di
L. 500 a km. il Comune dette L. 6.000 annue per cinquant'anni, sussidio
che poi passò alla Compagnie des chemins de fer du Midi de l'Italie.
I primi concreti passi verso la costruzione li registriamo in data 27
marzo 1900, quando venne accordata alla Societé anonyme des Tramways et
des Chemins de Fer du Centre, con sede a Lione (Francia), la concessione
per la costruzione e l’esercizio della ferrovia Napoli - Piedimonte d’Alife.
Tale concessione venne ceduta nel 1905 alla Compagnie des Chemins de Fer
du Midi et d’Italie con sede a Parigi. Venne previsto e, successivamente,
realizzato un progetto di ferrovia, a scartamento 950 mm, con trazione a
vapore, sulla tratta Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d’Alife e, con
trazione elettrica a corrente alternata monofase 11.000 V/25 Hz, sulla
tratta Napoli-Capua. Intanto i collegamenti con Caserta erano assicurati
attraverso l'impiego di automobili lungo la tratta Caserta-Santa
Maria C.V.-Caiazzo-Piedimonte d'Alife. Si
attuavano quattro corse giornaliere da e per Piedimonte. Nulla fu
trascurato perché il servizio funzionasse regolarmente e fosse uno dei
più importanti d'Italia meridionale. Le vetture erano spaziose, comode ed
eleganti; ciascuna per 14 viaggiatori seduti, come quelle che da anni
funzionavano in parecchi servizi della Svizzera, dove le strade
presentavano pendenze molto più forti di quella sotto Caiazzo. Malgrado tale pendenza le vetture da 14 posti riuscivano a
trasportare sino a 22 persone con 200 kg. di bagaglio, senza dar luogo al
più piccolo inconveniente. Le vetture erano anche illuminate nell'’interno
durante le corse notturne, e marciavano con velocità anche su strade di
montagna, potendo anche superare con facilità pendenze del quindici per
cento.
Il 30 marzo 1913 il treno entrò in funzione sul percorso Napoli (Piazza
Carlo III) - Santa Maria Capua Vetere (Biforcazione-Capua); il 31 dicembre
1913 fu inaugurata la tratta Biforcazione Capua – Caiazzo ed, infine, il 5
ottobre 1914 fu la volta del tronco Caiazzo – Piedimonte d’Alife (oggi
Piedimonte Matese).
Il primo treno arrivò a Piedimonte il 30 giugno 1914.
Durante la prima guerra ci fu la riduzione delle corse e, per mancanza
di carbon fossile, il nostro treno fu costretto ad andare a legna.
Impiegava nel viaggio parecchie ore, e stentava a superare l'ardua
salita di Caiazzo. Le corse tornarono normali dopo la guerra. Si ebbero
quattro corse quotidiane. A soli dieci anni dalla data di apertura,
l’esercizio passò ad una Gestione Commissariale Governativa: era il 14
aprile 1923.
Arrivata la seconda guerra mondiale, a causa di mancanza di carburante,
si ebbe uno straordinario affollamento e una rinnovata lentezza. Si
giunse così al 6 ottobre 1943, quando i guastatori tedeschi fecero
saltare, sulla tratta Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte d’Alife,
ogni 50 metri, i binari e quasi tutti i ponti. Anche la tratta bassa
subì dei danni all'infrastruttura ed al materiale rotabile ma con
conseguenze meno gravi. Al termine del conflitto fu possibile
ripristinare rapidamente la sola Alifana bassa tra Napoli e Santa Maria
Capua Vetere/Sant'Andrea dei Lagni, mentre la tratta alta, seriamente
danneggiata rimase interrotta, in attesa di decisioni sul futuro. A
complicare ulteriormente la ricostruzione, non giudicata prioritaria,
fu anche un lunghissimo iter burocratico, sia per la concessione dei
finanziamenti, sia per il mantenimento della concessione alla CFMI.
Arrivata la seconda guerra mondiale, a causa di mancanza di carburante,
si ebbe uno straordinario affollamento e una rinnovata lentezza. Si
giunse così al 6 ottobre 1943, quando i guastatori tedeschi fecero
saltare, sulla tratta Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte d’Alife,
ogni 50 metri, i binari e quasi tutti i ponti. Anche la tratta bassa
subì dei danni all'infrastruttura ed al materiale rotabile ma con
conseguenze meno gravi. Al termine del conflitto fu possibile
ripristinare rapidamente la sola Alifana bassa tra Napoli e Santa Maria
Capua Vetere/Sant'Andrea dei Lagni, mentre la tratta alta, seriamente
danneggiata rimase interrotta, in attesa di decisioni sul futuro. A
complicare ulteriormente la ricostruzione, non giudicata prioritaria,
fu anche un lunghissimo iter burocratico, sia per la concessione dei
finanziamenti, sia per il mantenimento della concessione alla CFMI.
L'8 luglio 1949, la discussione viene iniziata dal sen. Giacinto Bosco.
L'oratore richiama di nuovo l'attenzione del Ministro dei trasporti sul
problema della ricostruzione della ferrovia Piedimonte d'Alife-S. Maria
Capua Vetere, distrutta dalla guerra, e presenta un ordine del giorno
invitante il Ministro stesso a prendere i necessari provvedimenti in
conformità delle promesse già fatte dal Governo. Il sen. Giovanni Caso si
associa all'ordine del giorno suddetto.
Finalmente, avuto il decreto del Ministero dei Trasporti per la
ricostruzione dei 36 km. da S.Maria C.V. a Piedimonte, il 4 gennaio 1955
a Triflisco iniziarono i lavori. Nel 1957, finalmente, il Ministero dei
Trasporti concludeva, che "La Ferrovia Santa Maria Capua Vetere –
Piedimonte Matese era meritevole di ammodernamento". Sempre in quegli anni
venne deciso che la trazione sarebbe dovuta essere Diesel anziché
elettrica come richiesto dalla
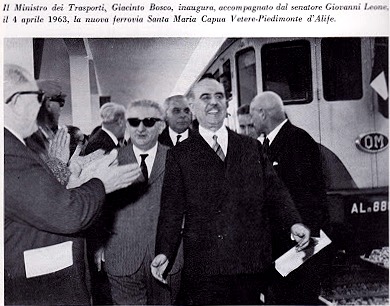 Società concessionaria. Si crearono così
due tronchi: Napoli Scalo Merci – Santa Maria Capua Vetere Sant’Andrea a
trazione elettrica in corrente alternata monofase 11.000 V e 25 Hz a
scartamento ridotto (950 mm) e Santa Maria Capua Vetere – Piedimonte
Matese a trazione Diesel con scartamento ordinario. Società concessionaria. Si crearono così
due tronchi: Napoli Scalo Merci – Santa Maria Capua Vetere Sant’Andrea a
trazione elettrica in corrente alternata monofase 11.000 V e 25 Hz a
scartamento ridotto (950 mm) e Santa Maria Capua Vetere – Piedimonte
Matese a trazione Diesel con scartamento ordinario.
A Piedimonte fu costruita una nuova stazione e una lunga pensilina, e il
4 aprile 1963 il treno vi entrava. Compie il suo percorso di km. 79 +
700 in ore 1,20 e per il trasporto merci in ore 1,50. L'interessamento
del ministro Giacinto Bosco era stato decisivo per la ricostruzione. Nel
giugno del 1969 la gestione passò alle T.P.N. tramvie provinciali
napoletane, e il 1° dicembre 1970 si ebbe il regolare contratto. Il 1°
gennaio 1978 fu costituito il "Consorzio trasporti pubblici per
Napoli" fra i comuni della linea. La linea, da
Biforcazione di Capua ha avuto qualche rimaneggiamento. Oggi abbiamo una prima
galleria a Triflisco, ma il più importante è quello di Caiazzo, dove
quattro tunnels evitano
di salire su tutta la collina. Il binario è a scartamento normale, le
curve sono larghe, le pendenze attutite. Al momento si sta lavorando
per l'elettrificazione e l'ammodernamento della linea ed il rinnovo
delle carrozze. Il problema di fondo è sempre e comunque la
disponibilità economica, anche se i lavori di elettrificazione pian
piano procedono. E' previsto che la linea elettrica arrivi sino a
Piedimonte Matese, l'attivazione, prevista per il 1° semestre 2008, è
ancora di là da venire. I treni sono degli elettrotreni Firema, di cui
uno già disponibile dovrebbe essere proprio in deposito a Piedimonte,
simili agli elettrotreni di ultima generazione usati dalla Cumana. |
|
Piedimonte passa alla provincia di Benevento |
|
La
politica accentatrice del Fascismo giunse alle sue conclusioni nel
quinquennio 1924-29 e fra le tante cose abolì i circondari. Anche
quello di Piedimonte fu soppresso col R.D. del 21 ottobre 1926. Parte
di esso -Piedimonte, Ailano, Alife, Castello, Gioia, Raviscanina, San
Gregorio, San Potito, Sant'Angelo, Valle Agricola e cioè il mandamento
di Piedimonte fu annesso alla provincia di Benevento, il mandamento di
Capriati fu unito a Campobasso, e quello di Caiazzo fu unito anche a
Benevento. Più precisamente la provincia di Terra di Lavoro fu
soppressa nel 1927 ed il suo territorio venne diviso fra le province di
Napoli, Roma, Frosinone, Campobasso
e Benevento. Nella provincia di Napoli fu incorporata la zona litoranea
fino al Garigliano
e tutta la fascia ad est di Napoli fino agli attuali limiti delle
province di Benevento ed
Avellino. Alla provincia di Benevento furono attribuiti i sedici comuni
della valle d’Alife a
partire da Caiazzo (cioè il territorio dell’ex circondario di
Piedimonte), alla provincia di Roma
la fascia litoranea a nord del Garigliano (posteriormente attribuita
alla nuova provincia
di Latina); nella provincia di Frosinone in coincidenza con la
soppressione di quella
di Caserta, furono incorporate la zona del Cassinate nonché quella
dell’alta valle del Liri;
alla provincia di Campobasso andarono infine 7 comuni dell’alta valle
del Volturno (Capriati
a Volturno, Prata Sannita, Gallo, Letino, Valle Agricola, Ciorlano e
Pratella). La
provincia fu ricostituita nel 1945 senza però la sua antica
circoscrizione territoriale. Restarono
infatti alla provincia di Frosinone e Latina i territori che furono
staccati da Terra
di Lavoro nel 1927, così come alla provincia di Napoli restò il Nolano.
Con Benevento, provincia ordinata e dignitosa pur nella sua minor
ricchezza, le cose non sarebbero andate male. Piedimonte era il terzo
centro, e le sue pratiche erano curate. Eppure non fu popolare. Si era
abituati a Terra di Lavoro, cui ci univa la ferrovia piedimontese e
quasi 700 anni di storia, fin dal giustizieriato angioino di Capua. Ma
Benevento era qualcosa di imposto, e perciò non sentito. (Oggi
esiste un gruppo ideologico che lavora affinché Piedimonte lasci la
provincia di Caserta ed entri a far parte dell'ipotizzata nuova regione
Molisannio, ndr). |
|
Gli
avvenimenti del 1943 |
|
Nel settembre-ottobre
1943 anche Piedimonte visse i suoi momenti critici e paurosi, e
dall'azione distruttrice dei tedeschi ebbe quel colpo quasi fatale, da
cui è andata lentamente risollevandosi.
La gioia dell'8 settembre pomeriggio, all'annunzio dell'armistizio, si
manifestò specie tra gli sfollati napoletani, ma fu una breve euforia.
L'11 settembre i soldati della 3a Div. Tedesca circondarono armati la
caserma di Finanza in via Sannitica, ma i finanzieri salvarono il
tricolore e le armi gettandole immediatamente dalle finestre tra i fichi
d'India. Iniziò il sistematico saccheggio del cotonificio, dove - come
in luogo sicuro - erano state depositate enormi quantità di tessuti,
anche dei cotonifici di Fratte di Salerno.
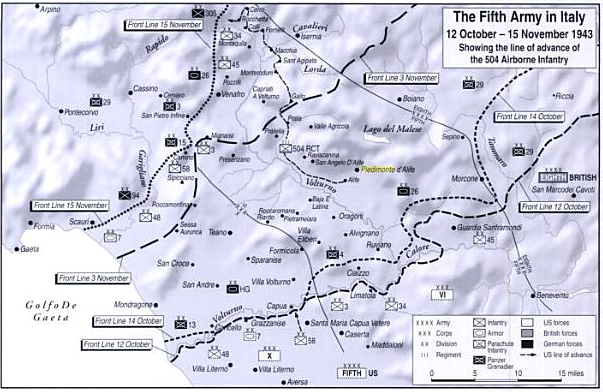
Il 13 ed il 14 vi
furono i primi saggi. Il 19 i Tedeschi si impossessarono dell' 'autobus
Fortuna e di tutta la suppellettile della rimessa, e dal 23 cominciò
l'interminabile asportazione di tessuti e balle dal cotonificio. Il 24
scoprirono il magazzino al secondo piano, occultato, e zeppo di roba. Il
25, di fronte a nuova e grande asportazione di tessuti, si decise di
sospendere il lavoro. Rimasero gli uomini. Il fronte si avvicinava e,
per chi si sarebbe lavorato?
Il 26 ci fu la requisizione dei quadrupedi, e i proprietari dovettero
fornire anche conducenti e mangime. Tutto il mercato era pieno di
animali in due file coi portatori, modesti contadini che se ne privavano
con dolore. Il luogotenente Fisher in dieci ore di tempo asportò al
cotonificio tutto il deposito di stoffe di Fratte, il luogotenente Ellemberg pretese la consegna di tutte le chiavi, e la Polizia intanto
saccheggiava i depositi della Ditta Riselli, riempendo gli autocarri.
Il 27 fu ordinata - pena la morte - la consegna di tutte le armi,
pugnali, macchine fotografiche, ecc., e intanto dal cotonificio
venivano portate via le macchine,
attrezzi e l'impianto della saldatura autogena. Gli operai stessi furono
obbligati a fare i pacchi, e, a fine giornata, ebbero dai tedeschi un pò
di olio, sottratto al Consorzio agrario. Pure il 27 si voleva mandare in
Germania gli operai del cotonificio, ma i giovani si nascosero e i
vecchi furono licenziati. 25 macchine portarono via enormi quantità di
tessuti, e i comandanti Kauser e Krause completarono il saccheggio dei
magazzini della ditta Michele Riselli. Il 28 dodici autocarri e il 29
altri undici continuarono il saccheggio, e in quel giorno da un
impiegato fu nascosta la cassaforte. Il 30, dopo aver
vietato l'ingresso agli ultimi operai presenti, i tedeschi cominciarono
a tagliare le cinghie e mentre dai nostri si nascondevano registri e
documenti, altri otto autocarri venivano caricati.
Il 1° ottobre continuò il saccheggio, che proseguì nei giorni
successivi. Finora la popolazione aveva seguito con ansiosa
preoccupazione quanto avveniva, prevedendo disoccupazione e fame, ma il
5 cominciò il vero terrore. Alle 5 di mattina la Polizia bloccò tutte
le vie di Piedimonte ed iniziò la caccia all'uomo per le strade e per
le case: 28 piedimontesi e molti dei paesi vicini furono spediti a
Cassino. Il 6 i guastatori fecero saltare i binari della ferrovia . Il 7
iniziò il saccheggio alla S.M.E. e cos' l'8 ed il 9. Nella serata del 9
ci fu il primo bombardamento. Verso le 21 un aereo americano volendo
colpire la Scuola Agraria, dove c'era l'ospedale militare ed il deposito
di munizioni, sganciò sei bombe che rovinarono varie case, e a san
Giovanni fecero le prime vittime: Filomena Arrigo e Maria Rapa.
Il 13, alle ore 12,10, i piedimontesi, molti dei quali si erano
rifugiati sul Cila, assistettero attoniti al massiccio bombardamento di
Alife, da cui si sollevavano sinistre colonne di fumo, il paese fratello
andava in gran parte distrutto! Fra i tedeschi un interprete inviperito
e scalmanato, ordinò vari saccheggi a case e negozi: era un italiano di
Perugia, il cui genitore, squadrista, era stato ucciso dagli
antifascisti dopo il 25 luglio. Ora voleva vendicarsi di tutti.
Il 14 nuova ondata di terrore. Armati di mitra, i tedeschi, dopo aver
bloccato le vie all'alba, ricominciarono la caccia all'uomo. Il 15
saltò in aria la condotta forzata della S.M.E., e poco dopo mezzogiorno
ci fu il secondo bombardamento a Sepicciano con sei vittime: Ant.
Iannotta, Domenico Cassella con moglie e figlia, Gaetana Leggiero e
Angelina Raccio.
Il 16 i guastatori prepararono la dinamite nel cotonificio. In giornata
saltò in aria la turbina e la centralina elettrica, venne incendiato il
palazzo Merolla, che bruciò per quattro giorni, e verso le 15 saltò in
aria parte della Centrale. Il 17 i guastatori minarono e incendiarono
Palazzo Ducale. Si rovinò, fra l'altro l'"Aurora" di Solimene,
un vero capolavoro! Verso le 15,
con uno scoppio orrendo, saltò in aria tutta la Centrale. Da parte
americana, poi, cominciò il cannoneggiamento su Piedimonte, e il 18
furono colpite alcune case di Vallata, l'Annunziata, il Palazzo Riselli
col Banco di Napoli. Cominciarono pure a cadere le case per effetto di
mine. Cinque tedeschi rimasero uccisi.
Ormai gli americani erano vicini, i loro cannoni tuonavano forte, ma
intanto il martedì 19, si ebbe l'ultimo atto di questa orribile
tragedia.
Di mattina furono appiccati incendi, saltarono tutti i ponti sul
Torano,
le case del centro, il Dopolavoro e la farmacia Petella, una delle più
attrezzate della provincia, e verso le 9 uno scoppio mai sentito di mine
collegate elettricamente, distrusse il cotonificio.
L'enorme fabbricato si sollevò polverizzandosi, proiettili volarono in
tutte le direzioni, e una nuvola di fumo arrivò all'altezza di Matese.
Fu una scossa violenta come il terremoto. Gli ultimi sette guastatori
lasciarono il paese verso le 11. Brutte cose allora successero a Porta
Vallata: sfollati abbrutiti dall'esasperazione seviziarono i cadaveri
dei tedeschi uccisi dalle cannonate. Potevano fare qualcosa prima.
Sarebbero stati eroi.
|
| Primo
grande alluvione |
|
Il 20 settembre 1841
c'era stato uno straripamento: Ma verso la mezzanotte del 23,
secondo la
cronaca dell'epoca, dopo
piogge violente dal tramonto, improvvisamente le acque invasero il
centro. Raggiunsero il primo piano delle case e la gente si rifugiò sui
tetti, disperata nel buio pesto, mentre sotto rumoreggiava un torrente
fangoso che trascinava pietre e i pali delle "troffe". Mentre
il Vallone devastava Vallata, il Rivo invase Piazzetta e Palazzo Ducale,
abbatté il ponte delle Scalelle, interrò l'androne sotto l'Episcopio e
si riversò per San Domenico, distruggendo la Dogana. Il Torano invase
orti e industrie abbatté il ponte di S. Arcangelo. Fu rovinata la villa
ducale, arenò la ramiera e il mulino, fu semidistrutto l'Ospizio
francescano e il lanificio al conservatorio, rotto l'acquedotto al ponte
S. Arcangelo e la città rimase senz'acqua. Morirono 16 persone in quella
tragica notte.
D. Marrocco non ci parla dell'alluvione del 23 dicembre 1841 riportato
nel testo: Della Città di Napoli, dal tempo della sua fondazione sino
al presente, nelle Memorie storiche di Francesco Ceva Grimaldi,
Napoli 1857. Si tratta forse di quello erroneamente datato il 23
settembre dal Marrocco?
Il 28 giugno 1842 Ferdinando II emanò un rescritto per cui venivano
stanziati 55.700 ducati per disciplinare i fiumi di Piedimonte, di cui
metà a carico della Tesoreria generale di Napoli, e l'altra metà per i
2/3 dalla Provincia ed 1/3, ratizzato, dagli industriali di Piedimonte.
Il 26 e il 29 ottobre, nuovo temporale e nuovo parziale allagamento. |
| Secondo
grande alluvione |
|
Fin dal 1842 si cercò
di porre argine allo straripamento del Torano e dei torrenti Rivo e
Valpaterno, e vi si spesero più di 100.000 ducati, ma inutilmente perché
il
13 settembre 1857,
al mattino, bastarono tre ore di piogge torrenziali. Sempre Vallone e
Rivo i maggiori colpevoli e il Torano faceva la sua parte. Le acque
raggiunsero al Carmine il primo piano e anche stavolta scene di terrore:
case sfondate, cadaveri galleggianti (ben 43 morti!).
Galleggianti sull'acqua le statue di S. Anna e della Madonna del
Carmine! Si arrivò a mettere mobili su mobili, e a sfondare pavimenti
per sfuggire dai "bassi" invasi. Un gran masso, rotolato dalla
piena, sfondò il portone della filanda Egg: fango e ghiaia sulle
macchine, grandi depositi di cotone grezzo e telerie distrutti, lavoro
sospeso per quattro mesi! La merce danneggiata fu venduta a metà
prezzo. Re Ferdinando mandò personalmente 800 ducati che uniti ai 609
di una sottoscrizione locale, procurarono un primo sollievo al popolo
rimasto affamato.
In seguito a questa ennesima strage e agli enormi danni - sui 200.000
ducati - si capì che si doveva affrontare la questione una volta per
sempre. Furono perciò costruite, finalmente, nei due anni seguenti,
colossali dighe alla Valle del Rivo e a Valle Paterno.
Venne scartato il progetto di ricostruire Piedimonte a Sepicciano.
Tuttavia la questione era ben lontana dall'essere risolta
definitivamente, infatti nella relazione di F. De Blasiis del 1867 sulla
Bonificazioni delle Paludi esistenti nelle province di Terra Ferma
dell'ex Regno di Napoli si sottolinea
che "le poche opere d'arte che vi esistono, briglie, catene ed argini,
furono eseguite dalla Provincia prima del 1855. L'Amministrazione
Generale non fece che riparare alle rotte avvenute, e tutto rimane da
farsi dopo accurato studio dei torrenti, ai danni dei quali conviene di
porre riparo. Si cominciò pure la costruzione di un canale irrigatorio,
di circa 4 chilometri, derivato dal Torano, ma fu poscia lasciato in
abbandono". Per questo motivo vi fu un "progetto per regolare
definitivamente il tronco del Torrente Valpaterno, dallo sbocco nella
valle del Maretto fino alla confluenza del fiume Torano, nonchè per
rettificare il tronco del fiume medesimo dalla detta confluenza fino al
partitoio delle sue acque, collo scopo di difendere l'abitato di
Piedimonte d'Alife, ma il Consiglio dei Lavori Pubblici lo rimandò
domandando modificazioni". Non se ne fece più nulla. |
|
Il ciclone del 30 e 31
dicembre 1974 |
|
Sono circa le 15 del
30 dicembre, da poco è cessato di piovere. Il cielo si presenta alquanto
strano: una linea dritta e molto lunga demarca la parte nuvolosa, fatta
di nuvole nere come la pece, da quella completamente serena. Questa
linea si posiziona nella direzione Monte Acuto- Monaco di Gioia (nord
ovest-sud est). Vista da Alife la catena montuosa presenta delle strane
nuvole che si sviluppano da terra verso l'alto, in senso verticale,
all'altezza delle montagne di Sant'Angelo d'Alife, località San Michele,
Monticello, nuvole a forma di imbuto. Già si incomincia a presagire
nulla di buono, una cosa così non si era mai vista precedentemente.
Verso le 15,30 incomincia a soffiare un vento teso, continuo, dalle
montagne (Nord) verso la pianura (Sud). Questo vento si fa sempre più
forte e, verso l'imbrunire, ha ormai raggiunto raffiche che toccano i
140 Km/h. Su tutta la linea pedemontana che va da Capriati al Volturno a
Gioia Sannitica è un'abbattersi di alberi, anche di alto fusto, un
volare di tegole, cartelloni stradali, impalcature. Diventa quasi
impossibile camminare a piedi, si rischia di essere sollevati da terra.
Chi si trova sfortunatamente in auto deve inserire la prima marcia e
procedere a passo d'uomo tra scossoni e sollevamento da terra della
carrozzeria. Nella pianura alifana i tralicci di ferro della corrente
elettrica vengono piegati a terra dalla furia del vento. Le prime case
incominciano ad avere il tetto scoperchiato. E' un suono continuo di
tegole che volano via. Il tetto della villa Di Cosmo (oggi Leone),
all'incrocio della villa comunale, viene letteralmente sollevato e posto
di traverso sulla stessa abitazione. I tramezzi di alcune palazzine in
costruzione vengono sfondati. Cessa l'erogazione dell'energia elettrica
e tutte le case si ritrovano al buio. Nella nottata si sente l'ululato
continuo e pauroso del vento che arriva dai valloni Paterno e dell'Inferno.
E' una nottata passata da tutti in bianco, si sente un martellare
continuo di tavole messe di traverso dietro i balconi prima che essi
volino via. La mattina del 31 il vento cala di intensità leggermente. I
piedimontesi ostinati a fare qualche acquisto per la cena del 31 escono
da casa calpestando un mare di tegole e calcinacci e guardando sempre in
alto. Lo spettacolo è desolante. Durante la tarda mattinata il vento
cala ulteriormente. Ora si può circolare a piedi senza alcun pericolo,
ma ancora non c'è l'energia elettrica, che tornerà solo il giorno 2
gennaio. La vigilia di capodanno del 1974, passata al lume di candela,
sarà ricordata per lungo tempo dai piedimontesi. |
|
Costituzione del reggimento di Fanteria Speciale a Piedimonte d'Alife. |
|
Il
reggimento Fanteria speciale si costituisce il 1° ottobre 1944 in
Piedimonte d'Alife per il Gruppo di Combattimento "Legnano", per
trasformazione del 3° reggimento alpini.
Lo costituiscono il battaglione alpini "Monte Granero", ottenuto per
trasformazione dell'omonima batteria di artiglieria alpina, battaglione
alpini "Montenero", già "Piemonte", battaglione bersaglieri "Goito" nel
quale confluisce il 4° reggimento bersaglieri, compagnia cannoni
controcarro da 57/50, ottenuta dal V battaglione controcarri, compagnia
mortai da 76. L'ordinamento del reggimento viene più volte manipolato ed
infine entra in linea con i battaglioni "Goito" bersaglieri, "Piemonte"
alpini (già "Montenero") e "Abruzzi" di nuova costituzione che dal 25
novembre diviene "L'Aquila".
Impegnato nelle operazioni del gruppo di combattimento "Legnano", il 21
aprile del 1945 entra a Bologna con i bersaglieri del "Goito", il 29
aprile è a Brescia, il 30 successivo a Bergamo.
Il reggimento, trasferito a Legnano si scioglie il 30 giugno 1946 per
ridare vita al 67° reggimento fanteria "Legnano". |
|
Pellegrinaggio per l'Anno Santo |
|
In occasione dell'Anno Santo indetto dal
papa Urbano VIII, il 16 novembre 1625, un numeroso gruppo di pellegrini
(300 uomini e 100 donne), con sacchi e mozzette bianche, partirono da
Piedimonte alla volta di Roma, ove furono ospitati
dall'Arciconfraternita della SS.Trinità. (Marsilio
Honorati, Tesori dell'Anno Santo, Roma, 1649) |
|
Il terremoto del
1688 |
|
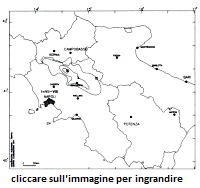 Dalla
documentazione storica risulta essere il
terremoto più devastante che abbia
colpito Piedimonte. Il
terremoto colpì alla vigilia della Pentecoste, attorno alle 18.30. La
scossa, secondo la testimonianza del Vescovo di Cerreto Sannita, Giovanni
Battista De Bellis, durò "tanto tempo quanto possa dirsi un Credo" e
rase al suolo gran parte dei paesi della sua Diocesi. Dalla
documentazione storica risulta essere il
terremoto più devastante che abbia
colpito Piedimonte. Il
terremoto colpì alla vigilia della Pentecoste, attorno alle 18.30. La
scossa, secondo la testimonianza del Vescovo di Cerreto Sannita, Giovanni
Battista De Bellis, durò "tanto tempo quanto possa dirsi un Credo" e
rase al suolo gran parte dei paesi della sua Diocesi.
Le testimonianze riportano scenari apocalittici: nelle piazze e viuzze
della città, immerse nella quiete del primo pomeriggio, risuonarono d'un
tratto i cupi boati dei crolli, seguiti dai gemiti di migliaia di feriti
e moribondi, le grida di terrore degli scampati che fuggivano come
forsennati verso le aperte campagne o si attardavano presso le macerie
delle proprie case piangendo i familiari sepolti.
A Benevento un denso polverone si alzò sulla città fino ad oscurare il
sole. Ben presto si poté avere la visione esatta della gravità della
sciagura: Benevento era stata letteralmente rasa al suolo. I morti
furono 2.115.
Lo stesso accadde a Cerreto Sannita dove circa 4.000 persone (metà della popolazione) morirono a
causa del sisma. Questa grave tragedia indusse il conte Marzio Carafa a
decidere di ricostruire il centro abitato (l'attuale) più a valle e su
di un suolo maggiormente stabile. Ad Alife caddero quasi tutte le case
causando la morte di oltre 30 persone. Ad Alvignano e nella Vallata di
Piedimonte perirono molte persone e per un certo tempo le acqua del
Torano si intorbidirono e lo stesso fiume cambiò il suo percorso.
[Approfondimento] |
|
Il terremoto del 2013 |
|
Il 29 dicembre 2013 un terremoto di
magnitudo MW = 5.0 (profondità 10.5 km) avvenne nell’area dei Monti del
Matese alle ore 18:08:43, ora locale. Il terremoto fu localizzato dalla
Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) nei Monti del Matese (41.37°N, 14.45°E). In seguito
a tale evento, diversi interventi furono predisposti e finalizzati al
miglioramento del monitoraggio geofisico dell’area. L’evento produsse
panico e preoccupazione, in modo particolare nelle comunità alle falde
del Matese, con un elevato livello di avvertibilità in tutta la
provincia di Caserta, Benevento, Napoli, Avellino e Salerno, in
Campania, e di Venafro ed Isernia, nel Molise. Nelle aree più prossime
all’epicentro furono registrati danni di lieve e media gravità ad alcuni
edifici e a strutture di culto. Per fortuna non vi furono danni alle
persone. L’evento fu tra quelli di maggiore energia registrati nell’area
del Matese dopo il terremoto del 26 luglio 1805. Considerato
l’elevato livello di pericolosità dell’area fu ritenuto opportuno
procedere ad un rilievo speditivo degli effetti del terremoto sulle
costruzioni, al fine di analizzare la vulnerabilità del patrimonio
edilizio (in gran parte costituito da centri storici ed edifici in c.a.
non antisismici) ed esaminare l’andamento della radiazione sismica,
elementi che potrebbero essere utilizzati in futuro in un’ottica di
mitigazione del rischio nel caso di eventi di maggiore energia. (Rapporti
Tecnici sul terremoto nel Matese del 2013) |
| |